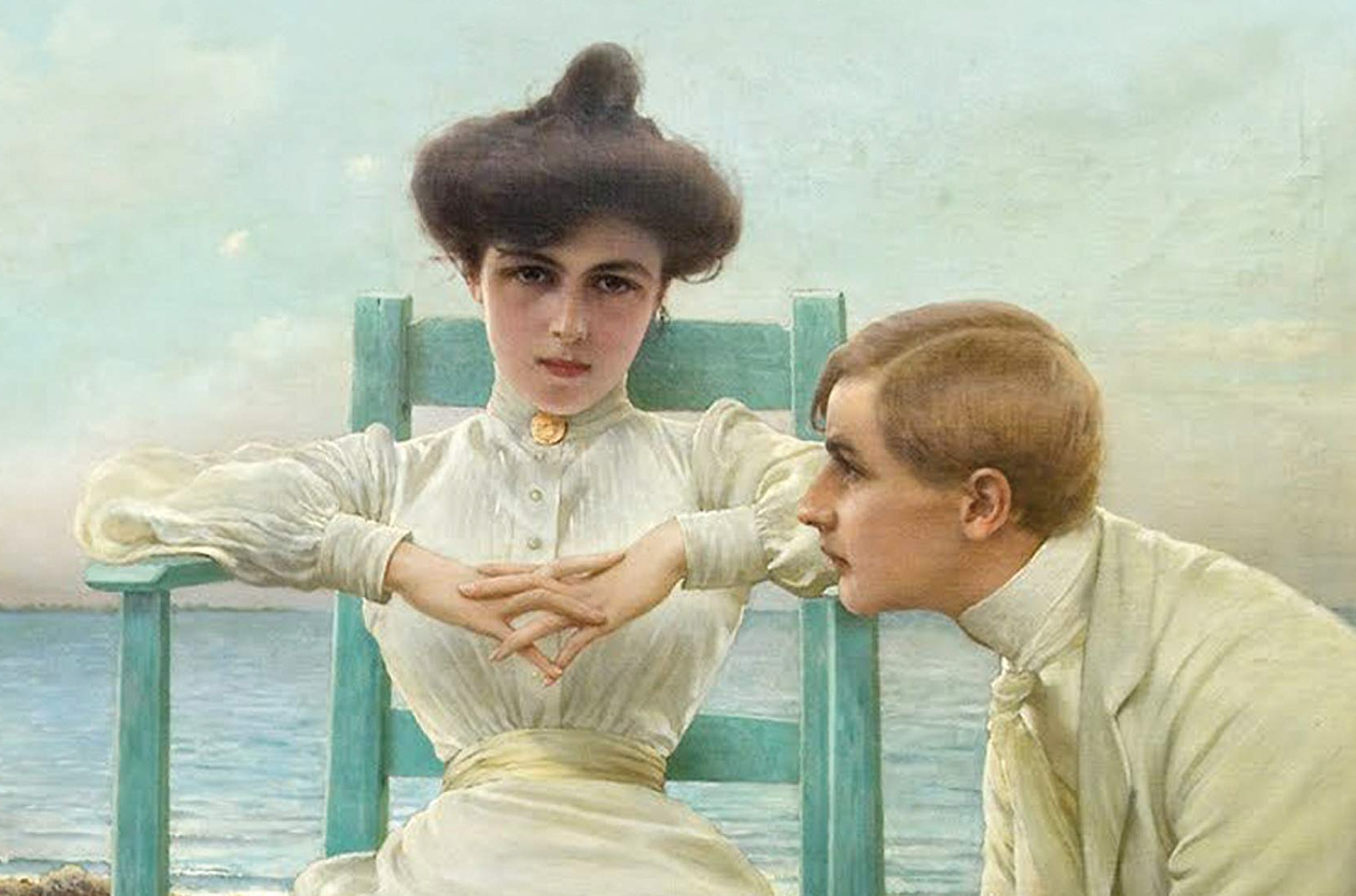È a tratti imbarazzante, ma ovviamente soprattutto tragico, il fenomeno per cui una massa di “persone istruite” determina il valore di una prova di un candidato. Il giudizio che avviene, in un contesto concorsuale, o all’interno di un profilo di più basso livello, come quello scolastico, è agghiacciante.

Non che qui si voglia richiamare contesti postmoderni di scetticismo imperante ove il malcapitato ha dalla sua la possibilità di fare appello ad una profonda mancanza di conoscenza generalmente diffusa, quanto declinabile in incertezze di ampio spettro. Piuttosto si sottolinea come l’atto “tipico della procedura didattica” sia in vero atto di violenza. E violenza estrema è quella che si fa di gruppo. Se il mio pubblico non fosse troppo puritano si potrebbe eguagliare l’atto, del tutto deprecabile, di un giudizio corale ed univoco, allo stupro di gruppo. Difatti ciò che avviene è una violenza di molti ai danni di uno. La correzione è, in tutti i casi, un’ingerenza nell’altrui sfera personale.
Ci vengono in aiuto alcuni termini correntemente, quanto orgogliosamente, utilizzati nel quotidiano del corpo docente: “dobbiamo dare una guida a questi ragazzi”, “risulta necessario premiare i meritevoli e correggere gli svogliati”, “solo con una adeguata preparazione questi ragazzi potranno muoversi nella società”. Il cipiglio paternalista è il primo passo per la conquista di quel “ruolo da piedistallo” che legittima il processo di correzione. La correzione è, per definizione, un atto in cui si “normalizza” qualcosa. Secondo regole. Le regole, in maniera dogmatica e tronfia, non vengono mai messe in discussione dal docente o, dal membro della commissione, o da chicchessia che abbia un ruolo giudicante. Non siamo del resto lontani dalla sfera del diritto dove il giudice è il garante supremo dell’applicazione di regole che governano un sistema artificiale.

L’inquisitore è, in fin de’ conti, un giudice che utilizza solamente un metro diverso. E nella robotica applicazione di “dotti” principi le singole vittime dell’educazione sono occorrenze di una ferita ben più ampia che colpisce l’umanità. Ingegno e creatività non possono trovare espressione in un siffatto sistema scolastico, e più largamente sociale dove le sovrastrutture sono impegnate in un quotidiano laborioso lavorio di livellamento. Questo effetto di correzione è una feroce potatura che parte da concetti semplici e socialmente condivisi per arrivare a qualsiasi tentativo di differire dalla norma. Ove per norma intendiamo semplicemente il costume più diffuso, il comportamento più in voga. Educati sin dalla tenera età alla figura di un correttore, mentre sogniamo nelle culle di essere valorosi Émile di Russoniana memoria, ci troviamo ben presto in un mondo di grandi che, pur navigando nelle più profonde oscurità esistenziali e cosmiche, a fronte di un “inconnu” che sovrasta e domina l’esistenza di tutti, sono pronti a giurare sulla Bibbia, siano essi “Ta biblìa” di religiosa o scientifica natura, la validità dei “sani principi”. La paura di ciò che non conosce, e ancor di più di ciò che non “può” conoscere, spinge questo stupido animale sociale che ha inventato trucchi immani per garantirsi un tozzo di pane, ad una dittatura del pensiero o, per essere più precisi, ad una dittatura della nozione che ha trovato nei contemporanei risvolti tecnologici la sua summa.

Orbene abbiamo ora interi contenitori dove mettere tutto lo scibile umano. Un sistema che si autogenera. Il complesso di Frankestein che vede macchine sempre più “intelligenti” capaci di ribellarsi al creatore, con le sue più ampie declinazioni cinematografiche che generano queste fabbriche di “nuovi automi”/”nuove macchine” create a loro volta da altre “macchine”, ben rappresenta, in verità, ciò che avviene nel sistema sociale umano e, più precisamente nelle more della nostra discussione, nel sistema culturale umano. Il tutto si intreccia con le menzogne delle dinamiche di gruppo. Al punto che non è vero ciò che è vero, ammesso che di vero qualcosa ci sia (questa sì, è una deriva postmoderna), ma è vero ciò che piace. È vero ciò che la maggioranza, stolida e cieca, definisce vero. Se il ragionamento a livello macroscopico appare troppo lasco, non sedendo sulle “solide basi della ricerca scientifica” (sic!), una trasposizione locale potrà facilmente semplificare quanto sinora detto. Magari passando per concetti di scienza sociale, come quello della profezia che si autoavvera, con buona pace di un vasto gruppo di lettori.
All’interno di un paesino di poche migliaia di anime, è diffusa la tendenza a parlar male degli assenti. Pertanto, la domenica, o in altri momenti di festa, quando si creano dei piccoli crocchi di persone intente a parlare fra di loro si assiste in maniera, questa volta permettetemelo, “scientifica”, alla ripetizione di un certo script. Ovvero al “parlar male” dell’assente. Ogni gruppetto, grazie all’attacco, più o meno melodrammatico, che i suoi membri, in qualità di attori sociali, mettono in scena, finisce col criticare ora questa ora quell’altra persona. Quando uno del gruppo lascia gli altri per dirigersi altrove, diventa, in maniera quasi naturale, l’oggetto delle prossime “attenzioni”. In generale le argomentazioni non devono essere per forza negative, il sistema potrebbe anche concentrarsi sulla semplice diffusione di informazioni. Cosa è in fondo un pettegolezzo se non una informazione? Ad ogni modo la tendenza alla denigrazione dell’assente è talmente forte che possiamo definirla come tratto caratterizzante del fenomeno (probabilmente si attesta tra l’80 e il 90% dei casi). Questo atteggiamento, che ben risponde a quella esigenza di auto affermazione e auto riconoscimento dell’umanità: “Noi siamo i giusti, nel giusto, non quello che è andato via che ha fatto questo, questo e quest’altro”… E qui si capisce anche come il processo, in tutti i sensi della parola, debba avvenire in contumacia per avere successo. Tale atteggiamento, si diceva, ben denota quella violenza di gruppo di cui sopra. Il piccolo gruppo di ”pari” trova il massimo punto della sua auto legittimazione nella differenziazione con ciò che è l’altro. E l’altro è sempre solo. Pertanto colui che lascerà il gruppo, verrà punito con l’immediata applicazione di tale processo. Ma se ognuno è vittima delle “dicerie” altrui, se ognuno è “coupable” di mancanze ignominiose, come fa allora ad essere giusto al tempo 1, ovvero prima di abbandonare il gruppo? Perché è ovviamente il gruppo a “sanare” le sue mancanze.

Quando l’individuo smette di essere individuo e diventa parte di un cerchio, magico o non che sia (si permetta qui una celia), solo allora la sua condizione di “mortale”, di proveniente da putulente seme di Jacoponiana memoria, viene abbonata, chissà forse solo dimenticata, e si oltrepassa la soglia che conduce alla giustizia, alla correttezza, al bene. A fronte del “male” del solo. Che il processo origini dalla necessità atavica di un gruppo formato, in maniera militare, per ottenere il successo della caccia, o che esso sia piuttosto l’aberrazione di un contesto sociale in cui la sopraffazione del simile è endemica e statuaria ai fini della sopravvivenza di altri soggetti più deboli non sta a noi dirlo. Ma il fenomeno ben si lega al gruppo dei colti che, ha ha ha, applicano la loro scure sull’ignorante che si pone loro dinnanzi.
Facile quindi comprendere come, sia in ambito scolastico, che all’interno di un concorso, che nelle più disparate dinamiche sociali legate al lavoro, all’istruzione e alla giustizia, perfino ad un qualsiasi processo burocratico, al centro della discussione non vi è mai cosa è giusto, cosa sia corretto (a volte per l’impossibilità di definire cosa realmente lo sia, altre semplicemente per dolo), bensì cosa il gruppo ritenga tale e quanto il singolo sia propenso ad abdicare a questa congrega di tiranni il suo giudizio e la sua libertà di espressione.