Il grande lavoro di Denis Villeneuve, accompagnato dalle musiche di Hans Zimmer, assume su di sé le caratteristiche, doverose ma per niente scontate, dell’epopea. La pellicola, con un cast d’eccezione che vede al centro della scena Timothée Chalamet, Jason Momoa, Stellan Skarsgård, Oscar Isaac, Zendaya, Javier Bardem, la carismatica Charlotte Rampling e la infaticabile e intensa Rebecca Ferguson, riprende, con ambizione – mai tradita in tutta la pellicola (anche quando il troppo dialogo sembra diluire la trama ndr) – gli sforzi letterari dello scrittore Frank Patrick Herbert (Premio Nebula nel 1965 e Premio Hugo nel 1966) e il sogno cinematografico di Alejandro Jodorowsky.
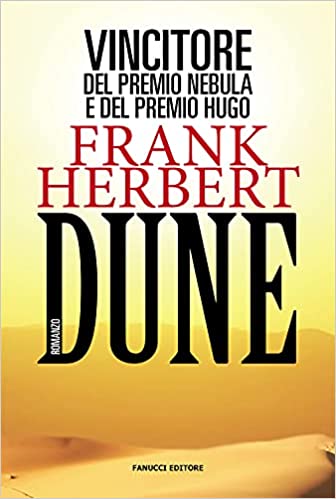
Narra la leggenda – e anche il documentario di Frank Pavich (Jodorowsky’s Dune, 2013) – che il campione della psicomagia mai ebbe modo di realizzare il suo sogno di vedere sulle schermo una versione della saga di Herbert, mettendo insieme le musiche dei Pink Floyd, lo sguardo magnetico di Salvador Dalí e Orson Welles e la scenografia e i costumi di Moebius, Chris Foss e Hans Ruedi Giger.
Il film di Villeneuve è “reverendissimo” e cattura, con l’aiuto di una fotografia a tratti troppo cupa e fredda, la gioia della vera letteratura diventando esso stesso opera letteraria: una pellicola filosofica e simbolica, in cui le parole affiancano e mai invadono, al cui centro sta la riflessione sulla natura umana, sul baratro senza fine del profitto opposto all’etica cavalleresca (Harkonnen contro Atreides).
I mezzi spaziali che emergono dalle sabbie del pianeta Arrakis, minacciosi parallelepipedi di ossidiana, sono un omaggio al monolite di Kubrick e rappresentano la volontà tutta filologica del regista di rendere sullo schermo un caposaldo temibile per gli addetti ai lavori.
Menzione speciale per i costumi per Bob Morgan e Jacqueline West, al carrefour fra la fantascienza d’ordinanza e la rivisitazione perfetta di una Westwood ecologista (ricordate i Pirate Boot?). Si sono ispirati, come hanno dichiarato, ai film di David Lean – Il Dottor Zivago, Lawrence d’Arabia – e a Fahrenheit 451, ma anche ai Tuareg, a Giotto, Goya e Caravaggio. Ma non solo, nell’immaginario dei costumisti anche le carte dei Tarocchi. Per un totale di più di mille abiti.
Personaggi grandi, sfumati e mai scontati si muovono in un ambiente in definitiva improbabile ma mai privo di credibilità umana. Una gioia per gli occhi in un periodo creativo di noia diffusa.
Il Barone Harkonnen, un Vito Corleone privo della dolcezza di fondo del personaggio di Brando, De Niro o Baldini, morde la storia con spietata e ripugnante bulimia di profitto e divide la scena dell’antieroe con Gaius Helen Mohiam, la Reverenda Madre della sorellanza Bene Gesserit: “La vecchia avvolta in un aba nero, il cappuccio calato sulla fronte, lasciò allora il corteo imperiale e venne a prendere posto dietro al trono. Appoggiò la mano nodosa sullo schienale di quarzo. Il suo viso, all’ombra del cappuccio, era la caricatura di una strega: occhi e guance infossate, naso protuberante, pelle butterata e solcata da vene sporgenti. Il barone alzò gli occhi su di lei e smise di tremare”. (Dune, pag. 347, Editrice Nord, 1973). Echi della deposizione del Caravaggio (1602-1604) nella scena in cui il Duca Leto giace nudo davanti al vorace nemico: “e resta supina la faccia, e ‘l petto pallido à morte“, diceva del dipinto Gian Pietro Bellori nel 1672 (Le vite de’ pittori, Scultori et Architetti moderni), e sembra che anche il fotogramma del film corrisponda perfettamente.

“I must not fear”, il mantra di Lady Jessica, la madre-sacerdotessa che ipnotizza la paura, è il leitmotiv che fa della storia degli Atreides un Bildungsroman a tutti gli effetti: “Non devo avere paura. La paura uccide la mente. La paura è la piccola morte che porta con sé l’annullamento totale. Guarderò in faccia la mia paura. Lascerò che mi calpesti e mi attraversi. E quando sarà passata, aprirò il mio occhio interiore e ne scruterò il percorso. Là dove andrà la paura non ci sarà più nulla. Solo io ci sarò.”
Il protagonista è un gender fluid Chalamet, circondato da muscoli, violenza e magiche ombre femminili di cui le gotiche pitonesse Bene Gesserit rappresentano l’apice massonico e misterico. Ma egli tuttavia regge la scena, incarna il prescelto Kwisatz Haderach, la perfetta sintesi fra Maschile e Femminile, pronto a impersonare in modo evangelico la memoria dei vinti (i Fremen), le istanze della religione, troppo spesso strumento di un Dio, o più Dei, di cartapesta e i diritti dell’individuo. In definitiva i diritti del cuore o il Primato della Coscienza. Un Giovanni Battista il cui annuncio, come nel Vangelo, echeggia nel deserto.
Dune non imita e non scimmiotta Lynch – la cui opera Jodorowsky definì “una merda” (intervista a cura di M. de Feo G. Giacobini, in Alias, supplemento de Il Manifesto, 4 luglio 1998) – ma pulisce la memoria comune dai tentativi cinematografici, e televisivi, precedenti, realizzando un Kolossal dalle grandiosità americane (effetti speciali di Gerd Nefzer e Paul Lambert, il cui nome è legato a Blade Runner 2049 e a First Man) e da un certo intimismo europeo.
Chi scrive ne riconosce la grandezza – con l’unica pecca narrativa di lasciare imprecisato il ruolo della Gilda, della spezia e dell’acqua che, carente, domina la storia – e ne attende il seguito.














